
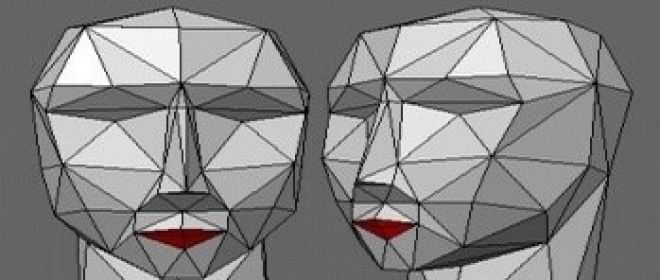
Il blog intende mettere in evidenza i risvolti filosofici delle tecnologie attuali più rivoluzionarie e mostrare come molte di queste tecnologie siano state anticipate dal pensiero dei filosofi antichi, in modo da riavvicinare il “classico” allo “scientifico”, il “tecnico” all’“umanistico”, termini che la cultura contemporanea considera radicalmente opposti, ma che parecchi secoli fa costituivano le due metà di una stessa mela.

Mario Abbati
Mario Abbati è nato a Roma nel 1966. Laureato in Ingegneria Elettronica e poi in Filosofia, ha trovato nella scrittura una dimensione parallela a quella di professionista nelle tecnologie dell’informazione.
Ha pubblicato i saggi “Ipercosmo, la rivoluzione interattiva, dai multimedia alla realtà virtuale” e “Manifesto del movimento reticolare”; la raccolta di racconti “La donna che ballava il tango in senso orario”; il romanzo, “Il paradiso delle bambole”.
TAGS
Apr 20
di Mario Abbati
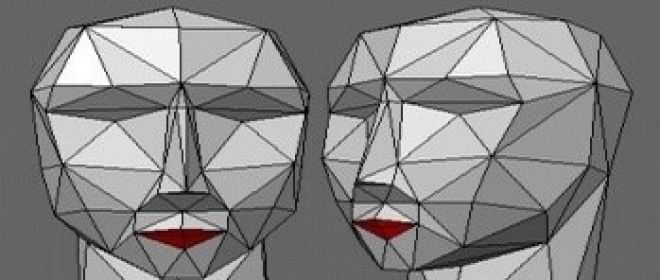
Negli anni ’90 del ventesimo secolo sembrava il rimedio
per cancellare i mali più terribili
dell’umanità, qualunque argomento si tirasse in ballo
– dall’arte alla medicina, dal marketing alla
sociologia – la realtà virtuale si
candidava come tecnologia rivoluzionaria in grado di arricchire il
bagaglio delle nostre esperienze superando i limiti palesi dei
cinque sensi.
Ah, dimenticavo: per realtà virtuale s’intende una
tecnologia che permette a un essere umano di
trovarsi in un ambiente simulato, cioè
costruito al computer, tale che la sua impressione soggettiva di
presenza sia, tendenzialmente, indistinguibile da quella che si
prova in un ambiente reale. Detto in soldoni: si
equipaggia un utente con un kit di sensori – cuffie, ottiche,
protesi tattili e rilevatori di movimento – e lo si spara
dentro un ambiente artificiale creato al computer, in modo che ad
ogni azione del primo corrisponda una reazione del secondo. Le
applicazioni sono le più svariate, basta indossare uno di
quei caschi sensoriali dal profilo aerodinamico e
si può volare dentro la copia in 3D della Basilica di San
Pietro, scendere lungo il corso dell’arteria femorale remando
nella marea dei globuli rossi, visitare il progetto simulato del
mio futuro appartamento prima ancora che venga costruito.
Ma di che materia sono costituiti i mattoni che compongono gli
ambienti virtuali? Sostanzialmente si tratta di
triangoli, unendo i quali si compongono tutte le
superfici del modello: è un po’ come avere a
disposizione un numero enorme, praticamente infinito, di triangoli
di tutte le forme e dimensioni e usarli come le tessere di
un mosaico per costruire volumi nello spazio; se i
triangoli sono sufficientemente piccoli e se ne possono usare
quanti se ne vuole, si potrà modellare con essi qualunque
superficie anche quelle più curve e irregolari.
Ora leggiamo con attenzione questo corsivo: “E prima di
tutto, che fuoco e terra e acqua e aria siano corpi, è
chiaro ad ognuno. Ma ogni specie di corpo ha anche
profondità; e la profondità è assolutamente
necessario che contenga in sé la natura del piano, e una
base di superficie piana si compone di triangoli… E tutti
questi elementi bisogna concepirli così piccoli che nessuna
delle singole parti di ciascuna specie possa essere veduta da noi
per la sua piccolezza, ma, riunendosene molte insieme, si vedano le
loro masse”.
A parlare è Platone, nel
Timeo, uno degli ultimi dialoghi che ci
ha tramandato duemilatrecento e rotti anni fa. Al netto della prosa
dal sapore accademico, la materia che il filosofo ateniese pone
alla radice dei quattro elementi fondamentali –
fuoco, terra, acqua e aria – è la
stessa materia di cui fa uso la realtà virtuale:
un’infinità di minuscoli triangoli
che cuciti insieme possono riprodurre qualsiasi mondo
possibile.
Una coincidenza? Un’interpretazione anacronistica? O
piuttosto l’effetto di una cultura arcaica a tutto tondo,
senza compartimenti stagni, che permetteva al libero pensatore di
postulare invenzioni avveniristiche pur non disponendo di computer
e protesi sensoriali?
© Riproduzione riservata
2262 visualizzazioni